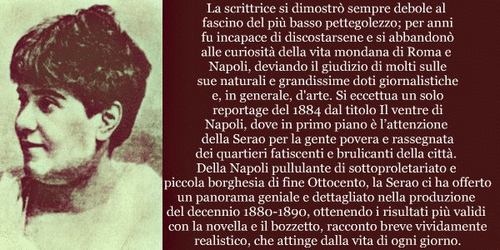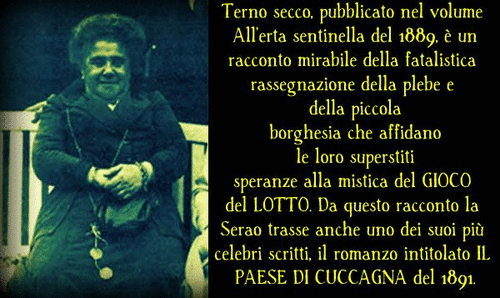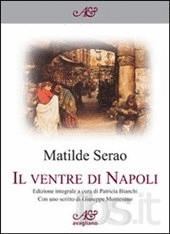Pubblicato per la prima volta nel 1890 a puntate sul quotidiano «Il Mattino» di Napoli, Il paese di cuccagna di Matilde Serao (1856-1927) apparve un anno dopo in volume presso l’editore Treves di Milano. Il talento di osservatrice appassionata che aveva caratterizzato la potente inchiesta Il ventre di Napoli (1884) viene qui applicato ad un aspetto particolarmente sentito nella realtà partenopea dell’epoca: il gioco del lotto.
Nato a Genova nella seconda metà del Cinquecento e ufficialmente introdotto a Napoli nel 1682, il lotto, si era profondamente radicato in città, suscitando entusiasmo e speranze, specie tra i più poveri. Il miraggio di un facile arricchimento che permettesse di approdare al “Paese di Cuccagna” superando d’un tratto le pene e le angosce di una vita di stenti era alla base della notorietà di questo gioco, il cui fascino era legato anche alle suggestioni cabalistiche a cui dava adito. Significativa a questo proposito la figura del cosiddetto “assistito”, che non poteva giocare personalmente i numeri che emergevano dai suoi sogni ma poteva comunicarli ad estranei; tale ruolo è rivestito nel romanzo dall’inquietante don Pasqualino, attorniato da «tutti coloro che credevano in lui e nelle sue visioni».
Il romanzo della Serao è una denuncia del gioco del lotto e dei suoi effetti devastanti su tutte le componenti della società napoletana. Già ne Il ventre di Napoli l’autrice aveva scritto : «Ma non credete che il male rimanga nelle classi popolari. No, no, esso ascende, assale le classi medie, s’intromette in tutte le borghesie, in tutti i commerci, arriva fino all’aristocrazia. Dove vi è un vero bisogno tenuto segreto, dove vi è uno spostamento che nulla vale a riequilibrare, dove vi è una rovina finanziaria celata ma imminente… ivi il giuoco del lotto prende possesso, domina…» E aveva aggiunto : «Il popolo napoletano, che è sobrio, non si corrompe per l’acquavite, non muore di delirium tremens; esso si corrompe e muore pel lotto. Il lotto è l’acquavite di Napoli».
Ma Il paese di cuccagna non è solo un romanzo sul lotto, né potrebbe esserlo. Alla tesi della rovina materiale e morale come conseguenza del gioco, esemplificata nei vari casi umani presenti nella narrazione, si affiancano infatti altri temi che emergono grazie a potenti descrizioni dal vero e che rendono il romanzo estremamente interessante anche per il suo carattere di documento: basti pensare al capitolo dedicato al miracolo di San Gennaro e al modo in cui viene vissuto dal popolo napoletano, alla descrizione del Carnevale o a quella della festa di battesimo in casa del pasticciere Fragalà con la minuziosa descrizione dei numerosi dolci tipici offerti agli invitati.
Lo sguardo della Serao, mai superficiale, si sofferma su ambienti, personaggi ed eventi senza scadere nel bozzettismo e nel “pittoresco”, con una barocca abbondanza di particolari a volte sbalorditiva. Ma se l’adesione alla vita reale ci riporta al clima del Naturalismo (e Verga solo due anni prima aveva pubblicato il suo Mastro don Gesualdo), non è possibile parlare però di uno sguardo impersonale: la prorompente personalità dell’autrice si afferma infatti in quella costante, amara ed appassionata volontà di denuncia che aveva già contraddistinto Il ventre di Napoli.
E appare significativo il giudizio espresso da Pietro Pancrazi nella sua introduzione a Serao, volume I in Romanzi e racconti italiani dell’Ottocento (Milano, 1944):
«Tra cent’anni, quando non si sapesse più nulla di Napoli, questo libro basterebbe a resuscitarla».
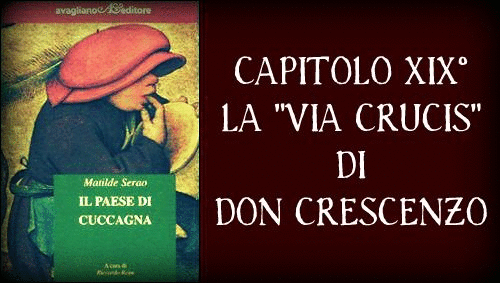
[…] L’Intendente era stato durissimo: non poteva più usare nessuna compiacenza verso il tenitore del Banco lotto, troppa ne aveva usata e non voleva parer complice delle sue frodi. Frodi, aveva detto e ripetuto, malgrado che avesse visto il pallore mortale di cui si era coperto il volto di don Crescenzo, udendo le due sillabe crudeli. Con lo Stato non si scherza: lo Stato non fa credito. Ogni settimana, ai versamenti di don Crescenzo, mancavano delle somme, e ogni settimana bisognava invocare la indulgenza, la pazienza del ministero delle finanze, a Roma, perché aspettasse il pagamento del sempre più grande debito, che don Crescenzo veniva contraendo verso lo Stato: ogni settimana! Ma lo Stato non è una banca che può accordare dilazioni: lo Stato fa aspettare, ma non aspetta! E ogni volta che nominava lo Stato, questa parola gli riempiva severamente e sonoramente la bocca, all’Intendente, ed egli aggrottava un poco le sopracciglia. Don Crescenzo ascoltava col capo chino, sussultando quando udiva nominare quell’ente misterioso, a cui tutto si deve dare e che non dà nulla, che non ha cuore, che non ha visceri e che stende le mani aperte, per prendere, per portar via. Ah l’Intendente era stato anche preciso, nella sua crudeltà! Per mercoledì ci voleva il versamento totale di tutto quello che si sarebbe esatto, come giuocate, e del debito arretrato: se no, la catastrofe era inevitabile: lo Stato incamerava la cauzione e dava querela per appropriazione indebita a don Crescenzo.
Costui aveva dato solo in un lamento, alle ultime parole dell’Intendente.
– Perdete il denaro e andate in carcere, – aveva conchiuso il degno funzionario.
Don Crescenzo si era messo a pregare, allora; aveva moglie e figli, se era stato tanto ingenuo da far credito ai giuocatori, doveva esser rovinato per ciò? Gli dessero tempo, li avrebbe costretti a pagare, avrebbe ridato allo Stato fino all’ultimo centesimo, era un galantuomo, infine, ingannato, assassinato!
– Anche voi giuocate, e a credito, – disse fieramente l’Intendente.
– Per rifarmi, Eccellenza…
– Un onesto tenitore non giuoca mai. Il lotto è una immoralità, nei cittadini…
– Allora anche lo Stato è immorale?
– Lo Stato non può esser immorale, ricordatevelo. Pensate a pagare, io non posso fare più nulla per voi. […]
Quando aveva giuocato la prima volta, lui, lui che avrebbe dovuto salvarsi da quella lebbra, viverne solamente senza farsene attaccare, viverne come si vive bevendo il veleno senza morirne, mentre quel veleno sopra una ferita aperta, uccide, – quando aveva giuocato? Non si rammentava più, vedeva una grande confusione, in cui solo la parola mercoledì si disegnava, con tanto vivido calore che pareva di fuoco, che pareva lo dovesse abbruciare.
Tutta una confusione, in cui la malattia mentale dei cabalisti che si affollavano nella sua bottega di giuoco e le cui mani febbrili toccavano le sue comunicandogli la loro febbre, il cui denaro strappato, Dio sa come, Dio sa dove, passando dalle loro mani alle sue, gli dava la emozione di un dramma, quella malattia mentale che ardeva il loro sangue, vecchi e giovani, poveri e ricchi, potenti ed oscuri, si era trasfusa in lui, dalla presenza, dal contatto, dall’ambiente, filtrando per tutte le cose, emanando da tutte le persone, e lentamente, lentamente, gli si era diffusa per le vene, penetrando nella sua vita istessa. Prima, per l’ardore del guadagno aveva fatto credito ai cabalisti, ritenendosi sempre il tanto per cento sulle loro giuocate a credito, mentre chiedeva dilazioni pel suo debito al Governo: poi, come lo spostamento si veniva facendo sempre più grave, come il buco si faceva più profondo, più profondo, fino a diventare un precipizio, aveva cominciato a giuocare anche lui, il disgraziato, tentando la sorte, con la illusione che la sorte lo favorisse, giuocando a credito, con la fatale, con la tremenda illusione che potesse guadagnare una grande, una immensa somma. Ah, il disgraziato lo sapeva bene, lo sapeva, che non se ne pagavano di vincite, che raramente; lo conosceva bene il terribile ingranaggio per cui le vincite sono la rarità quasi introvabile, sono la probabilità infinitesimale, sono proprio come l’incontro di un pianeta con un altro, ogni due o trecento anni, nelle inflessibili leggi siderali. […]
Non osava entrare in casa sua, ora, malgrado che si facesse tardi. Era disceso per Santa Brigida e per via Molo alla Marina, dove abitava una di quelle alte e strette case, in cui si penetra dagli oscuri vicoli di Porto e che guardano il mare un po’ scuro, fra la dogana e i Granili: e dalla via Marina, lungo la spiaggia dove erano ancorate e ammarrate le barche e le barcaccie dei pescatori, egli guardava, fra le mille finestre, la finestrella illuminata, dietro la quale sua moglie addormentava il suo bambino. Ma non osava rientrare, no; tutto non era dunque finito? Sua moglie avrebbe letto la sentenza, la condanna, sul suo volto, ed egli non reggeva a questa idea. Una fiacchezza lo teneva, sempre più grande, spezzandogli le braccia e le gambe, in quell’oscurità, in quel silenzio, dove solo le carrozzelle che portavano i viaggiatori ai treni partenti la sera, dove solo i trams che vanno ai comuni vesuviani mettevano ogni tanto una nota di vitalità, nella bruna e larga via Marina. Non reggendosi, si era seduto sopra uno dei banchi della lunga e stretta Villa del Popolo, il giardino della povera gente, che rasenta il mare: e di là, vedeva sempre, sebbene più lontana, lontana come una stella, la finestrella illuminata della sua piccola casa. Come rientrare, con qual coraggio portare le lacrime e la disperazione in quel pacifico, felice, piccolo ambiente? E quel bimbo innocente e l’altro che doveva nascere, e la madre così gloriosa di suo marito, del suo fanciulletto, doveva lui, lui, in quella sera farli fremere di dolore e di onta? Ah questo, questo gli era insopportabile! Un castigo così grande, così grande, piombato sulla testa di tutti, come se fossero i maledetti, distruggendo la salute, la fortuna, l’onore, tutto!
E in una successiva visione, egli riannodò tutte le fila di quel castigo, partendo da sé, a sé ritornando, andando dalla propria disperazione a quella altrui, sempre guardando il breve faro luminoso, dove la sua famiglia aspettava. E rivide la faccia pallida e smunta di Ninetto Costa che partiva per un assai più lungo viaggio, certo, che quello di Roma, lasciando un nome di fallito e di suicida a sua madre; rivide il corpo colpito di apoplessia dell’avvocato Marzano, le labbra farfuglianti e la miseria atroce, per cui non aveva neppure il denaro necessario per comperare dell’altro ghiaccio, mentre su di lui si aggravava un’accusa disonorevole, svergognante la sua canizie; e il professor Colaneri, scacciato dalle scuole, accusato di aver venduto la sua coscienza di maestro, e dopo aver buttato l’abito talare, costretto a rinnegare la religione, dove era nato, di cui era stato sacerdote; e la tristezza del dottor Trifari, navigante in un battello di emigranti, senza un soldo, privo di tutto, mentre i due suoi vecchi genitori tornavano, per aver pane, a scavare l’arida terra; e la rassegnata dedizione di Cesare Fragalà, dedizione in cui era finito il nome dell’antichissima ditta e in cui eravi tutto un avvenire di miseria da affrontare; e infine, su tutto, la malattia di cui moriva la fanciulla Cavalcanti, mentre suo padre non aveva più un tozzo di pane da portare alla bocca.
Tutti, tutti castigati, grandi e piccoli, nobili e plebei, innocenti e colpevoli; ed egli insieme con loro, egli e la sua famiglia, castigati in tutto quello che avevan di più caro, la fortuna, la felicità della casa, l’onore. Una schiera d’infelici, dove coloro che più piangevano, erano i più innocenti, dove le piccole creature, dove le fanciulle, dove le donne scontavano gli errori degli uomini, dei vecchi, una schiera di miserabili, a cui mentalmente egli aggiungeva gli altri che conosceva, di cui si ricordava: il barone Lamarra, sulla cui testa la moglie teneva sospesa l’accusa di falsario e che era tornato a far l’appaltatore, sotto il sole, nelle vie, fra le fabbriche in costruzione; e don Domenico Mayer, l’impiegato ipocondriaco, che in un giorno di disperazione, non potendone più dai debiti, si era buttato dalla finestra del quarto piano, morendo sul colpo; e il magistrato Calandra, dai dodici figliuoli, tenuto così in mala vista, che arrischiava ogni sei mesi di esser messo a riposo; e Gaetano il tagliatore di guanti che aveva ammazzato sua moglie Annarella, con un calcio nella pancia, mentre era incinta di due mesi, e nessuno aveva saputo nulla, salvo i due figliuoli che odiavano il padre, poiché anche a loro, ogni venerdì, prometteva di ammazzarli, se non gli davano denaro; e tutti, tutti quanti, agonizzanti e pur viventi fra le strette del bisogno e il rossore dell’onta; ed egli, infine, che aveva la sua famigliuola là, nella picciola casa, quietamente aspettante, mentre egli non aveva il coraggio di tornarvi, sapendo che la prima notizia della loro sventura gli avrebbe abbruciato le labbra.
Tutto un castigo, tutta una punizione tremenda: vale a dire la mano del Signore che si aggrava sul vizioso, sul colpevole e lo colpisce sino alla settima generazione; anzi lo stesso vizio, la stessa colpa, quel giuoco infame, quel giuoco maledetto, che si faceva istrumento di punizione, contro coloro che di questo vizio, di questa colpa si erano fatti il loro idolo; nella istessa passione, come in tutte le altre, che sono fuori della vita, fuori della realtà, nella passione istessa il germe, la semente della durissima penitenza. Colpiti dove avevano peccato, anzi dal peccato istesso! Tutto un lungo scoppio di pianto, da tutti gli occhi, dai più puri, uno scoppio di singulti dalle più pure labbra: una folla di povere creature oneste, dibattentisi fra la fame e la morte, scontando gli errori altrui, dando ai colpevoli il rimorso di aver gittato le persone che più amavano, in quell’immenso abisso.
Non uno salvo, non uno, di quelli che avevano dato la loro vita al giuoco, all’infame giuoco, al giuoco sciagurato, divoratore di sangue e di denaro: neppur lui salvo, neppur la sua famiglia, anche lui spezzato, anche i suoi figli ridotti, certo, a stendere la mano.
Ah troppo grande, troppo grande, insopportabile il castigo! Che aveva egli fatto, per dover esser lì nella strada come un mendico che non osa rientrare al suo tugurio, non avendo potuto avere l’elemosina dal duro cuore degli uomini? Che aveva fatto lui, per dover andare in carcere, come un malfattore, perché sua moglie si vergognasse di appartenergli e i suoi figli non nominassero più il suo nome? Ah era troppo, era troppo: che colpa aveva dunque commessa?
Una coppia di guardie passò nella via Marina e interrogò con lo sguardo le oscurità della banchina e della Villa del Popolo: l’ombra era profonda, le guardie non videro don Crescenzo, disteso sul sedile. Ma egli, come per un rapido cambiamento di scena, si vide dinanzi agli occhi, nel Banco lotto suo, al vico del Nunzio, le ardenti sere del venerdì e le affannose mattinate del sabato, in cui i giuocatori si affollavano ai tre sportelli del suo Banco, con gli occhi accesi di speranza e le mani tremanti di emozione: e rivide i cartelloni a grandi numeri azzurri e rossi, che incitavano i giuocatori a portare nuovo denaro al lotto: rivide i cento avvisi dei giornali cabalistici e i motti: Così mi vedrai! – Sarò la tua fortuna! – Il tesoro del popolo! – L’infallibile! – Il segreto svelato! – La ruota della fortuna! – e le visite frequenti dell’assistito e le fatali connivenze con tutti gli altri cabalisti, frati, spiritisti, matematici, che infiammavano i giuocatori col loro strano gergo, con le loro strane imposture: rivide le settimane di Natale, di Pasqua, in cui il giuoco diventa furioso, feroce, tanto è il desiderio del popolo di entrare nel sempre sognato Paese di cuccagna e si rivide sempre lui, contento di quelle illusioni che finivano in una dolorosa delusione, contento che quel miraggio acciecasse i deboli, gli sciocchi, gli ammalati, i poveri, gli speranzosi, tutti quelli che desideravano il Paese di cuccagna, contento che tutti, tutti quanti fossero attaccati da tale lebbra, che niuno se ne salvasse: contentissimo, quando, nelle grandi feste, cresceva l’ardore, e cresceva il giuoco, e cresceva il suo tanto per cento. Vide tutto, lucidamente, dalla sua persona che si curvava a scrivere sui registri le cifre maledette e le promesse fallaci, alle facce rosse o scialbe dei giuocatori, roventi di passione. E piegò il capo, abbattuto, sentendo di aver meritato il castigo, egli stesso, la sua famiglia, fino alla settima generazione. Il giuoco del lotto era una infamia che conduceva alla malattia, alla miseria, alla prigione, a ogni disonore, alla morte: ed egli aveva tenuto bottega di quell’infamia
Lo scandalo della miseria in una denuncia indirizzata a Depretis.Tra i vicoli di Napoli dove scorre la vita
“Egregio Capo del Governo, Lei sa tutto dell’Italia. Deve, perché Lei è il Governo, e il Governo deve sapere tutto. A Lei arrivano le statistiche della mortalità e quelle dei delitti; i rapporti dei prefetti, degli ispettori di polizia, dei delegati, dei direttori delle carceri. Il Governo sa tutto: quanta carne si consuma in un giorno e quanto vino si beve in un Paese; quante femmine disgraziate, diciamo così, esistano, e quanti ammoniti vi siano tra i loro amanti di cuore, quanti mendichi non possano entrare nelle opere pie, quanti vagabondi dormano in strada, la notte; quanto s’impegni al Monte di Pietà e quanto renda il lotto; la differenza tra i nuovi nati ed i morti, l’andamento del commercio, del turismo, dell’inflazione, della disoccupazione.
“Tuttavia vorrei farLe una domanda: le persone che si nascondono dietro tante cifre, ognuna con testa, bocca, occhi, orecchie e quant’altro, ognuna con un suo “io” e una sua storia, queste persone Lei le ha mai incontrate? Sa cosa mangiano (e più spesso non mangiano), cosa pensano, quanto desidererebbero dare ai propri figli un’educazione simile a quella che Lei ha dato ai Suoi, quante ore, instancabilmente, si “arrangiano” per lavorare anche quando risultano disoccupati? Glielo chiedo in modo particolare pensando a Napoli, la mia città”.Firmato Matilde Serao, indirizzato a Agostino Depretis, Presidente del Consiglio nel l905: un secolo fa.E’ il fulminante “attacco” de Il ventre di Napoli, il capolavoro di Matilde Serao (1856- 1927).Il ventre di Napoli è spesso stato considerato, un sia pur abilissimo reportage. Questo col tono benevolo e sprezzante che i letterati di professione hanno avuto, soprattutto nella prima parte del Novecento, per i libri dei giornalisti. Reportage, nel severo linguaggio di questi gufi che personalmente di rado conoscevano altre realtà se non il proprio studio e qualche caffè letterario, di solito era sinonimo di serie B: “instant book”, o ripubblicazione di vecchi articoli ammanniti al pubblico depurandoli dell’eccessiva attualità. Ma su Il ventre di Napoli nessun giudizio potrebbe essere più falso. E’ la stessa autrice a dirci, in una nota introduttiva, che fu scritto in tre tempi, tanti quanti sono i suoi capitoli. E la prima parte, forse la più bella – quella che entra nei bassi di Napoli, nel loro lezzo, nella promiscuità, nel vizio, ma anche nell’intensità di quel brulichio di vita – fu scritta lontano da Napoli, vent’anni dopo il colera che devastò la città. E testimonia della capacità, fatta di talento ma anche di mestiere, di questa scrittrice considerata da molti contemporanei una non scrittrice, a cominciare dl marito Edoardo Scarfoglio, amico di D’Annunzio e del “bello scrivere”, che in seguito lei lasciò. Più tardi anche Benedetto Croce, che all’inizio l’aveva apprezzata, ne diede giudizi negativi. L’antipatia, del resto, era ricambiata.Già nella prima pagina possiamo leggere che “non sono fatte per il Governo(che deve sapere la verità, ndr) le descrizioncelle colorite di cronisti con intenzioni letterarie, che parlano del mare glauco, del cielo di cobalto, delle signore incantevoli e dei vapori violetti del tramonto. Questa retorichetta a base di golfo e colline fiorite serve per quella parte di pubblico che non vuole essere seccata con racconti di miserie”. Del resto, la Serao aveva già scritto chiaramente, nel precedente Dal vero, che si può descrivere con molta esattezza ciò che non si è visto, o che magari si è visto ma se ne è lontani. E’ proprio quello che fa la prima parte del libro.
Ci sono poi una seconda e una terza parte, di cui la terza analizza fuori dai luoghi comuni quello che potremmo chiamare “l’eterno napoletano”, dalla pizza alla superstizione, e la seconda è l’unica datata. La scrittrice trova monumentali e “moderni” – anche avvertendo subito che si tratta solo di “un paravento”- quella piazza Garibaldi, quel Rettifilo, quel Palazzo della Borsa che a noi oggi paiono così logori e invecchiati
Ebbene, a questo popolo eccezionalmente meridionale, nel cui sangue s’incrociano e si fondono tante gentili, poetiche, ardenti eredità etrusche, arabe, saracene, normanne, spagnuole, per cui questo ricco sangue napoletano si arroventa nell’odio, brucia nell’amore e si consuma nel sogno: a questa gente in cui l’immaginazione è la potenza dell’anima più alta, più alacre, inesauribile, una grande fantasticheria deve essere concessa.È gente umile, bonaria, che sarebbe felice per poco e invece non ha nulla per essere felice; che, sopporta con dolcezza, con pazienza, la miseria, la fame quotidiana, l’indifferenza di coloro che dovrebbero amarla, l’abbandono di coloro che dovrebbero sollevarlaFelice per l’esistenza all’aria aperta, eredità orientale, non ha aria; innamorata del sole, non ha sole; appassionata di colori gai, vive nella tetraggine; per la memoria della bella civiltà anteriore, greca, essa ama i bianchi portici che si disegnano sull’azzurro, e invece le tane dove abita questa gente, non sembrano fatte per gli umani, e dei frutti della terra, essa ha i peggiori, quelli che in campagna si dànno ai maiali; e vi sono vivande che non assaggia mai.Ebbene, il popolo napoletano rifà ogni settimana il suo grande sogno di felicità, vive per sei giorni in una speranza crescente, invadente, che si allarga, si allarga, esce dai confini della vita reale: per sei giorni, il popolo napoletano sogna il suo grande sogno, dove sono tutte le cose di cui è privato, una casa pulita, dell’aria salubre e fresca, un bel raggio di sole caldo per terra, un letto bianco e alto, un comò lucido, i maccheroni e la carne ogni giorno, e il litro di vino, e la culla pel bimbo e la biancheria per la moglie e il cappello nuovo per il marito.Tutte queste cose che la vita reale non gli può dare, che non gli darà mai, esso le ha, nella sua immaginazione, dalla domenica al sabato seguente; e ne parla e ne è sicuro, e i progetti si sviluppano, diventano quasi quasi una realtà, e per essi marito e moglie litigano o si abbraccianoAlle quattro del pomeriggio, nel sabato, la delusione è profonda, la desolazione non ha limiti: ma alla domenica mattina, la fantasia si rialza, rinfrancata, il sogno settimanale ricomincia. Il lotto, il lotto è il largo sogno, che consola la fantasia napoletana: è l’idea fissa di quei cervelli infuocati; è la grande visione felice che appaga la gente opp
ressa; è la vasta allucinazione che si prende le anime.Ed è contagiosa questa malattia dello spirito: un contagio sottile e infallibile, inevitabile, la cui forza di diffusione non si può calcolare. Dal portinaio ciabattino che sta seduto al suo banchetto innanzi al portoncino, il contagio del lotto si comunica alla povera cucitrice che viene a portargli le scarpe vecchie da risuolare; da costei passa al suo innamorato, un garzone di cantina; costui lo porta all’oste che lo dà a tutti gli avventori, i quali lo seminano nelle case, nelle officine, nelle altre osterie, fino nelle chiese.La serva del quinto piano, a destra, giuoca, sperando di non far più la serva; ma tutte le serve, di tutti i piani, giuocano, tanto la cameriera del primo che ha le trenta lire al mese, quanto la vajassa del sesto, che ne prende otto, con la dolce speranza di uscir dal servizio, così duro; e si comunicano i loro numeri, fanno combriccola sui pianerottoli, se li dicono dalle finestre, se li telegrafano a segni. La venditrice di frutta, che sta sotto il sole e sotto la pioggia, giuoca, e dal suo angolo di strada, in giù, la moglie del sarto, che cuce sulla porta, la moglie dello stagnino affogata dal fetore del piombo, la lavandaia che sta tutto il giorno con le mani nella saponata, la venditrice di castagne che si brucia la faccia e le mani al vapore e al calore del fornello, la venditrice di noci che ha le mani nere sino ai polsi per l’acido gallico, tutte queste donne credono nel lotto, giuocano fedelmente, ardentemente, al lotto.Nella stanza stretta, dove otto o dieci ragazze lavorano da sarte, e il bimbo della sarta dorme nella culla e in un angolo frigge il lardo nel tegame sul focolare, una dà i numeri, una seconda ne ha degli altri, la maesta sa i veri, tutte costoro giuocano.Le pettinatrici del popolo, le cosidette capere, dal grembiule arrotolato attorno alla cintura, dalla testa scapigliata, dalle mani unte, che pettinano per un soldo al giorno, portano in giro i numeri alle loro clienti, ne ricevono in cambio degli altri, sono il gran portavoce dei numeri. In tutte le officine dove gli operai napoletani sono riuniti a un lavoro lunghissimo, così male retribuito, il lotto mette radici profonde; in tutte le scuole popolari giuocano le maestre e giuocano le alunne grandicelle, in comitiva, riunendo i soldi della colazione. Dove sono riunite, a vivere di peccato, le disgraziate donne di cui Napoli ha così grande copia, il lotto è una delle più grandi speranze: speranza di redenzione.Ma non credete che il male rimanga nelle classi popolari. No, no, esso ascende, assale le classi medie, s’intromette in tutte le borghesie, in tutti i commerci, arriva sino all’aristocrazia. Dove vi è un vero bisogno tenuto segreto, dove vi è uno spostamento che nulla vale a riequilibrare, dove vi è una rovina finanziaria celata ma imminente, dove vi è un desiderio che ha tutte le condizioni dell’impossibilità, dove la durezza nascosta della vita più si fa sentire, e dove solo il danaro può esser rimedio, ivi il giuoco del lotto prende possesso, domina.Segretamente, giuocano tutte le ragazze da marito che non hanno un soldo di dote; giuocano tutti i numerosi impiegati al Municipio, alle Banche, all’Intendenza, al Dazio Consumo; tutti i pensionati che non possono vivere con la pensione e che non avendo nulla da fare fanno la cabala, studiano la scienza negromantica del lotto, giuocano disperatamente e hanno sempre il libretto in pegno; tutti i commessi di negozio, che guadagnano quaranta lire al mese, sanno i numeri certi e li giuocano ogni settimana.
Grande reddito, al lotto, lo dànno i magistrati: pagati miserevolmente, essi che rappresentano la più grande equità morale, esposti a tentazioni che respingono con una inflessibilità degna di maggior premio, provvisti di molti figli, rovinati dai traslocamenti, la loro debolezza, la loro speranza consiste nel lotto.I piccoli commercianti che si dibattono continuamente con le cambiali e fanno una lotta quotidiana col fallimento, finiscono per aggrapparsi a questa tavola così incerta del lotto; i grandi giuocatori di borsa, che vivono sopra il taglio di un rasoio e son capaci di ballarvi sopra un waltzer, a furia di febbre del giuoco, assaggiano volentieri la speranza del lotto. Tutti questi sintomi del male saliente alle classi dirigenti, mi constano, per aver visto, udito, compreso e intuìto.Le signore dell’aristocrazia giuocano, un po’ per burletta, un po’ con la speranza di un nuovo braccialetto, un po’ per l’oppressione di una nota di sarta che il marito non salderà mai. Anche quelli che dovrebbero esserne salvi, perchè abituati al male, perchè ci stanno sempre in mezzo, gli impiegati dei banchi-lotto, i postieri, non possono resistere alla tentazione. Onde, alle quattro del sabato, tutti quelli che sono più ammalati, non possono più aspettare, e si recano all’Impresa, in una stretta strada fra la via Pignatelli e la via di Santa Chiara, per assistere alla estrazione dei numeri.Ma tutte le serve, le venditrici, le operaie e gli operai, le ragazze e gl’impiegati non possono muoversi di dove sono. E allora un monello parte, va al più vicino posto del lotto e prende i numeri: tutti aspettano… Le persone più franche si fanno sulla porta e alle finestre, le vergognose restano dentro, tendendo l’orecchio. Il ragazzo torna correndo, affannato, si pianta alla bocca del vicolo e grida i numeri, con vocestentorea:
“Vintiquatto!””Sissantanove!””Quarantanoie!””Otto!””Sittantacinche!”
Silenzio universale: tutti impallidiscono.Ma come tutti i sogni troppo pronunziati, il lotto conduce alla inazione ed all’ozio: come tutte le visioni, esso porta alla falsità e alla menzogna; come tutte le allucinazioni, esso conduce alla crudeltà e alla ferocia; come tutti i rimedi fittizi che nascono dalla miseria, esso produce miseria, degradazione, delitto.Il popolo napoletano, che è sobrio, non si corrompe per l’acquavite, non muore di delirium tremens; esso si corrompe e muore pel lotto. Il lotto è l’acquavite di Napoli.
Il lotto ha una prima forma letteraria, rudimentale, analfabeta, fondata sulla tradizione orale come certe fiabe e certe leggende. Tutti i napoletani che non sanno leggere, vecchi, bimbi, donne, specialmente le donne, conoscono la smorfia, ossia la Chiave dei sogni a memoria e ne fanno speditamente l’applicazione a qualunque sogno o a qualunque cosa della vita realeAvete sognato un morto?- quarantasette – ma parlava – allora quarantotto – e piangeva – sessantacinque – il che vi ha fatto paura – novanta. Un giovinotto ha una coltellata da una donna? – diciassette, la disgrazia – diciotto, il sangue – quarantuno, il coltello – novanta, il popolo. Cade una casseruola dal suo chiodo, ammala un bimbo, fugge un cavallo, compare un grosso sorcio: numeri, subito.Tutti gli avvenimenti, grandi e piccoli, sono considerati come una misteriosa sorgente di guadagno. Muore una fanciulletta di tifo; la madre giuoca i numeri, escono, ella esclama: m’ha fatte bbene pure murenne! Una moglie parla dell’amore che le portava suo marito, che è morto; poi soggiunge malinconicamente, che se questo amore fosse stato grande, egli le sarebbe comparso in sogno, per darle i numeri; e se n’è scordato, è un ingrato, poichè egli lo sa che essa è poveretta e dovrebbe aiutarla.Salvatore Daniele squarta la Gazzarra: biglietto; il popolo dice: chella è mmorta, mo, almeno ce refrescasse a nnuie, che simmo vive. Salvatore Misdea ammazza sette soldati: biglietto. La legge ammazza Misdea: biglietto. Su le porte, nei bassi, alle cantonate, i numeri sono discussi da comitati e sottocomitati; il biglietto è stabilito. Non esce: avevano sbagliato, dovevano mettere questo numero e quest’altro, che sono usciti.Questa scienza della smorfia è così profonda, così abituale, che per dare del pazzo a qualcuno si dice: è nu vintiroie (ventidue, matto), e crescendo man mano la collera, tutte le ingiurie avendo un numero relativo, si dicono in gergo del lotto. Una donna dà un pugno ad un’altra, e le rompe la faccia; davanti al giudice, si scolpa, dicendo: m’ha chiammata sittantotto; il giudice deve prendere la smorfia e vedere a che corrisponde di oltraggioso quel numero.La cabala esiste più per le classi superiori che per le inferiori: ma essa vi discende. Certo, nel popolo non si comprano giornali cabalistici, settimanali, dagli strani titoli: il Vero amico, il Tesoro, il Fulmine, il Corno d’abbondanza, che costano dieci lire all’anno di abbonamento, compilati da una redazione ignota; nè il popolo corrisponde con quei professori di matematica che abitano al vico Nocelle dodici, o a San Liborio, quarantotto, o a vico Zuroli, tre, e che dànno, nelle quarte pagine, la fortuna a chi paga le dieci lire. Ma qualche cosa vi trapela: il tal signore sa i numeri, lo aspettano nella strada, gli mettono in mano un paio di lire e quello si contenta: è un piccolo affare.L’assistito (dagli spiriti) è un cancro che rode le famiglie borghesi, un convulsionario pallido che mangia molto, che finge di avere o ha delle allucinazioni, che non lavora, che parla per enigmi, che fa credere a delle macerazioni crudeli e che vive alle spalle di coloro che lo venerano. Ma, dalla casa borghese, per mezzo della cameriera, del servo, della lavandaia, la reputazione dell’assistito arriva nel popolo; e l’assistito vi estende la sua azione mistica, vi raccoglie dei guadagni piccoli, ma insperati, vi fa degli adepti e finisce per camminare nelle vie, circondato sempre da quattro o cinque persone, che lo corteggiano e studiano tutte le sue parole.Ma il grande aiutatore del popolo, la provvidenza del popolo, la sua fede, la sua credenza incrollabile, è il monaco. Il monaco sa i numeri: questo è il domma. Se non li dice, è perchè il Signore gli ha proibito di aiutare i peccatori; se li dice, e non escono, è perchè nel giuocatore è mancata la vera fede; se li dice e vengon fuori, la novella si spande in un minuto, il povero monaco diventa afflitto da una popolarità pericolosa. È come l’artista che ha fatto un capolavoro: guai se non continua a farne, egli è perduto. Il monaco che ha solamente fatto prendere un ambo, ha speranza di viver quieto: ma colui che ha dato tre numeri e sono usciti tutti tre, stia in guardia. Cercheranno di sedurlo in tutti i modi, coi doni, coi regali di denaro, con le offerte, con le messe, con le elemosine; lo faranno pregare dai bimbi, dalle donne, dalle nonne vecchie; l’aspetteranno in istrada, alla porta della chiesa, presso il confessionale, alla porta del convento; andranno a raccomandarsi a sua madre, a suo fratello, a sua zia; lo assedieranno mattina e sera; lo bastoneranno; lo sequestreranno, torturandolo; lo lasceranno morire di fame, perchè almeno in agonia dia i numeri. Sono cose accadute. Spesso, per salvarsi, un monaco si fa mandare da un paese all’altro, dal suo superiore; scompare, il popolo dice che se lo ha portato via la Madonna.Il popolo napoletano giuoca per quanto più ha denaro. Per quanto sia povero, trova sempre sei soldi, mezza lira, al sabato, da giuocare; ricorre a tutti gli espedienti, inventa, cerca, finisce per trovare. La sua massima miseria non consiste nel dire che non ha pranzato, consiste nel dire: Nun, m’aggio potuto jucà manco nu viglietto; chi ascolta, ne resta spaventato. Fra il venerdì sera e il sabato mattino, è tutto un agitarsi di gente che vuol giuocare e che non ha denaro; gli operai si fanno anticipare una giornata, le serve rubano orrendamente sulla spesa, i mendicanti nelle vie crescono smisuratamente dal venerdì al sabato, quello che si può ancora vendere, si vende, quello che si può impegnare, si impegna. Anzitutto vi sono i biglietti popolari da giuocare, quelli che si giuocano sempre, perchè è una tradizione, perchè è un obbligo, perchè non se ne può fare a meno: l’ambo famoso, sei e ventidue; il terno famoso, cinque, ventotto, e ottantuno; il terno della Madonna, otto, tredici e ottantaquattro. Questi terni, per fortuna del governo, non escono che ogni venti anni: quando è uscito, dopo moltissimi anni di attesa, l’ambo sei e ventidue, il governo ha pagato due milioni di piccole vincite, di cinque e di dieci lire l’una; e tutta Napoli si è coperta di tavolelle, vale a dire che tutti hanno pranzato o cenato con la vincita, per ricominciare a giuocare, la settimana dopo, con maggior ardore.
E ognuno ha il suo biglietto speciale, che gioca ogni settimana, da anni ed anni, con una fede che mai non crolla: un lustrascarpe ne giuocava uno da trent’anni e glielo aveva lasciato in eredità suo padre, morendo, insieme con la cassetta per lustrare; erano usciti degli ambi, tre o quattro volte, in trent’anni; il terno, mai. Un portinaio ne giuocò uno, per quarantacinque anni, senza prender mai nulla: la prima settimana che per un caso singolare, se ne scordò, il terno uscì – il portinaio morì di dolore.E vi è sempre il biglietto del grande avvenimento, rissa o suicidio, revolverata o veleno; e infine vi è il biglietto cabalistico, quello strappato all’assistito o al monaco.Questi quattro biglietti bisogna giuocarli a ogni modo; rappresentano una media variabile da cinquanta centesimi a due lire la settimana. Quando il napoletano non ha più che due soldi, li va a giuocare al gioco piccolo, o lotto clandestino.Per lo più le mezzane di questa grande frode, sono le donne. Una di queste, sudicia, lacera, porta in una lunga tasca, sotto la gonnella, un registro: viene il giuocatore o la giocatrice, deposita due soldi e dice i numeri: in cambio ha un pezzetto di carta sporca, dove sono scritti col lapis i numeri e la promessa, invariabile: uno scudo l’ambo… quaranta scudi il terno. La donna compie il suo giro nel quartiere, tutti la conoscono, tutti sanno che mestiere fa, tutti l’aspettano: denunziarla? Nessuno l’oserebbe, è una benefattrice.Questi introiti sono larghi naturalmente; a furia di due soldi si arriva a centinaia e centinaia di lire: i tenitori di gioco piccolo arricchiscono quasi tutti.Alla Riviera s’incontrano degli equipaggi di ricchi borghesi, arrivati a questa ricchezza col lotto clandestino; si conoscono perfettamente le persone, ma esse non compaiono, hanno i loro agenti. Il popolano ha una cieca fede in questi tenitori di gioco piccolo: ma bene spesso, nel pomeriggio del sabato, se il tenitore ha da pagare molte vincite, si affretta a sparire, con tutti i suoi registri, e non paga nessuno. Che importa?La settimana appresso un’altra donna ricomincia il suo giro e la gente ci capita di nuovo, come attratta, invincibilmente. Che delizia per chi giuoca e per chi prende i quattrini, frodare il governo!Ogni tanto la questura arresta quattro o cinque di questi agenti, di queste mezzane, essi sono condannati al carcere, alla multa; che importa? Scontano la pena, pagano la multa, escono, ricominciano da capo, con più ardore. Vi è chi è stato condannato cinque volte per gioco piccolo: e ha un palazzo, e si lagna della persecuzione del governo, e la sua condanna la chiama na disgrazia. L’aver messo il biglietto a due soldi, non è valso a nulla, pel governo: la frode ha continuato, più fiorente, appoggiata su questa grande allucinazione.Ora la statistica porta: che nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, avvengono maggiori furti domestici; che in questi tre giorni si fanno più pegni al Monte di Pietà, che in questi tre giorni le agenzie private di pegni, sono affollatissime; che in questi tre giorni, ma specialmente nel pomeriggio del sabato, avvengono maggiori risse; che infine le cose più brutte, più laide, più ignobili e più violente avvengono in questo fatale periodo, e che in questi giorni il popolo napoletano si mette nelle mani dell’usura: il vero cancro, di cui muore.